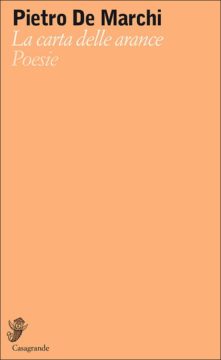Antichi aeroplanini al decollo, bolle di sapone… Non è infrequente, tra le metafore del fare poesia, l’immagine dello stacco da terra, della levitazione. Ma quella trovata da Pietro De Marchi nella poesia che sigilla La carta delle arance e gli dà titolo ci porta assai peculiarmente dentro le ragioni e le pulsioni di un’esperienza di scrittura in cui hanno parte fondante, radicale, la consapevolezza dell’effimero e, ad avversarla, l’ostinazione che pretende l’iterazione del miracolo. Capiamo allora, giunti al punto apicale del libro e della trilogia che esso conclude, come De Marchi sia riuscito – accensione dopo accensione, verso dopo verso – a farci riconoscere, nel volto del bambino protagonista della poesia di congedo, il nostro stesso volto. Lo ha fatto alimentando il desiderio di esserci, di essere chiamati a testimonianza, di poterci affacciare sulla scena per una qualche minima battuta che ci perpetui: fino a che il desiderio si dissolve e insieme si realizza nell’affidamento alla capacità di ascolto di questo straordinario captatore di voci, detti, storie, ritmi. De Marchi è il poeta che è per questa sorridente pietas che gli fa sentire il nostro insopprimibile desiderio di essere accolti, amati, sottratti – per quanto sospensivamente – a un destino di cenere: noi, «tutti con dentro un capogiro / a pensare di ripartire / senza lasciare un segno / che siamo stati qui».
(Rodolfo Zucco)
- Veröffentlicht am Sonntag 1. Januar 2017 von Edizioni Casagrande SA
- ISBN: 9788877137432
- 112 Seiten
- Genre: Belletristik, Lyrik, Taschenbuch